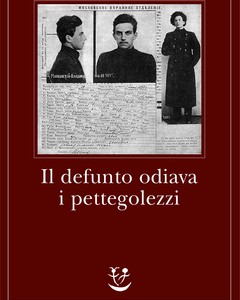Fuori dal paese, dopo l’ingresso del cimitero, c’è una strada che attraversa i campi coltivati e gli uliveti e che porta dritta da Stornara a Cerignola. La percorrono soprattutto mezzi agricoli e qualche pulmino che porta al lavoro i braccianti e i magazzinieri dell’agricoltura. Uno di questi si ferma appena un paio di chilometri più avanti e sparisce dietro a un muro di cinta crollato in parte. L’autista e i suoi passeggeri vivono lì, nel cosiddetto “ghetto dei bulgari”, una delle tante bidonville del foggiano, dove in condizioni inumane abitano i lavoratori stranieri della terra, pagati così poco da non potersi permettere più di una baracca tra i rifiuti, e costretti ad accettare incarichi a giornata sempre più al ribasso, in un settore dove è forte la presenza della criminalità organizzata. Nonostante l’incremento dei controlli alle aziende, delle denunce, dell’azione sindacale contro il caporalato, ogni anno migliaia di persone si ritrovano in condizioni di estrema fragilità non solo lavorativa: d’estate è il troppo caldo e la troppa fatica, d’inverno è il tentativo di fronteggiare il freddo a uccidere.
Lo scorso 17 dicembre qui sono morti due bambini di due e quattro anni, Birka e Christian, fratello e sorella, nel rogo della loro baracca. Il padre era al lavoro, la mamma si era allontanata di qualche decina di metri per andare in bagno, in un luogo che non ha alcun tipo di servizio igienico, né acqua corrente. La stufa ha fatto partire un incendio, in pochi minuti le pareti della casa, assemblata con materiali di risulta, sono state avvolte dal fuoco.
Da allora i bulgari di Stornara, la popolazione straniera più numerosa nella zona, sono tornati alla ribalta delle cronache locale e nazionale per qualche giorno, ma del ghetto si è parlato sempre come campo rom, e non come l’ennesima dimora degli sfruttati del settore agricolo, un problema che non può essere risolto da un piccolo comune che non raggiunge i seimila abitanti e che nei periodi di massimo impiego, con la raccolta del pomodoro, arriva a contarne qualche migliaio in più.
“La stagione per noi comincia a marzo con gli asparagi – spiega Stefan – adesso siamo in pochi perché d’inverno si lavora di meno e molti di noi preferiscono tornare in Bulgaria per uno o due mesi. Io non sono partito perché lavoro in un magazzino di frutta e verdura, ho pure un contratto regolare, nel senso che ho uno stipendio mensile, ma le giornate dichiarate in busta paga sono sempre meno di quelle lavorate”. Stefan siede con la moglie nel bagagliaio dell’auto, aperto, come fosse un piccolo divano. Ivan si avvicina a salutarli e si ferma a raccontare la bellezza della sua terra, dove ci sono il mare, le montagne, paesaggi mozzafiato e case in muratura per chi può permettersi di comprarle o costruirle. “A mancare sono gli stipendi che consentano di fare una vita decente – spiega – altrimenti in Bulgaria si potrebbe vivere bene; se qui per sei ore di lavoro in un magazzino puoi guadagnare fino a quaranta euro, da noi prendi venti lev. Eppure siamo tutti europei”.
Un lev equivale a 51 centesimi di euro, quindi la paga giornaliera si aggira intorno ai dieci euro. Petar ci ha provato, a fare il magazziniere a casa sua, e mostra ancora il tesserino della sua vecchia azienda. Non era sostenibile, non riusciva a mantenere la famiglia con quella cifra. Ha deciso di venire in Italia, lasciando a casa la moglie e la figlia. Solo che nel ghetto ha cominciato a bere, inizialmente per combattere il freddo, poi sempre di più ed è diventata una dipendenza. “Consuma tutto quello che guadagna in alcolici – dice Ivan – e non riesce mai a mettere da parte i soldi per tornare a casa. Purtroppo non tutti riescono a mantenere la testa sulle spalle in un posto del genere. Non siamo abituati a vivere così, io per esempio vengo a lavorare qui per finire di costruirmi la casa nel mio Paese. Lavorando lì non basterebbe una vita”. Nel frattempo Petar, quarant’anni da compiere, conta gli spiccioli nel palmo della mano, per assicurarsi che bastino per una birra, o un cartone di vino, prima di allontanarsi verso il paese.
Secondo i dati Istat aggiornati all’inizio del 2021, i cittadini bulgari residenti in Italia sono 56.873, dei quali 3.791 in Puglia, 2.073 nella sola provincia di Foggia. Ai dati ufficiali bisogna poi aggiungere i lavoratori stagionali che non hanno una residenza stabile, né un contratto d’affitto, e che variano sensibilmente di numero nel corso dell’anno. Nel solo campo di Stornara, dove oggi ci sono poco meno di trecento abitanti, l’estate si arriva a sfiorare il migliaio di presenze. A differenza di altri ghetti della zona, dove si trovano per lo più adulti, questa baraccopoli ospita anche molti bambini, figli delle coppie che arrivano qui per lavorare e che non hanno nessuno a cui affidarli.
Per questi minori, oltre ai rischi legati alle condizioni di privazione, si aggiunge l’isolamento: nessuno di loro frequenta la scuola e altri luoghi differenti da uno sterrato pieno di rifiuti. Nelle famiglie con figli a seguito sono le madri a rinunciare al lavoro per accudirli, mentre i padri devono raddoppiare le giornate se vogliono far quadrare i conti, accettando paghe ancore più basse per accaparrarsi il lavoro che altrimenti, come dicono qui, danno agli africani che si accontentano di pochi euro.
“Noi siamo fortunati perché abbiamo lasciato i bambini in Bulgaria con mia madre – spiega Verska, una ragazza con i capelli raccolti in una lunga coda e un vecchio cardigan addosso – così possiamo lavorare entrambi mentre loro vanno a scuola e dormono in una casa vera”.
Verska vive a pochi metri dalla casa dove sono morti i due bambini, ora quasi completamente occupata da rifiuti. Ha da poco finito di fare colazione con altre donne e bambini, tutti seduti attorno a un tavolo di fortuna fatto di mattoni mobili e assi di legno, mentre il marito, poco più in là, sta cercando di far ripartire l’auto. “Vengo qui a lavorare da quattro anni, ma non più nei campi – dice – adesso vado solo nei magazzini di frutta e verdura perché sono stanca della terra, ho cominciato a quindici anni.”
Oggi di anni ne ha venticinque, il suo primo figlio dieci e il secondo cinque. Dopo essere rimasta incinta al secondo anno delle superiori ha lasciato la scuola, si è sposata e ha cominciato a lavorare. Il marito ha la sua stessa età. Viene da Silven, come tutti gli altri bulgari di Stornara, la città che ha il triste primato europeo di gravidanze fra le minorenni: “Faccio tutto questo perché un domani loro non si ritrovino come me, così giovani a fare una vita da adulti”. Verska, il marito e gli altri abitanti del ghetto pagano 40 euro al mese a testa ai proprietari del terreno, una famiglia di pregiudicati locali. “Ogni tanto vengono a fare le pulizie con una ruspa – spiega un’altra giovane donna, incinta – e portano via i rifiuti”. La pulizia del campo consiste nell’ammassare la spazzatura in mucchi più grandi per poi dirottarli verso la discarica abusiva che si trova dietro l’accampamento.
A Stornara si dice che una soluzione potrebbe essere la confisca dell’appezzamento e l’assegnazione a un’organizzazione antimafia, che avrebbe in gestione gli alloggi per i lavoratori stagionali bulgari. Finora il Comune non ha ottenuto l’appoggio necessario, e dopo la riunione dell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza, che si è svolto in Prefettura a Foggia a seguito dell’incendio di dicembre, la Regione ha assicurato di voler intervenire nel ghetto, con vaccinazioni anti Covid e un’operazione di rimozione dei rifiuti. Nulla di risolutivo, se continua a mancare una possibilità abitativa diversa perché nessuno guadagna tanto da potersi permettere un affitto. “Dopo il rogo molti se ne sono andati da qui, perché hanno avuto paura che gli portassero via i figli – dice la ragazza incinta – nessuno parla volentieri di quanto è accaduto, ma poteva capitare a chiunque di noi, non è colpa di quei genitori”.