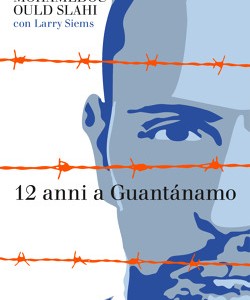Gonzo journalism significa indagare in prima persona, sporcarsi le mani con la realtà materiale, utilizzando il proprio corpo come viatico e strumento dell’indagine stessa. Significa vivere l’assoluto e la totalità della storia che si vuole raccontare, diventare la storia stessa, per poi riuscire a darle voce e forma, arrivare anche a mettere in gioco la propria vita, senza concessioni a barriere o protezioni di “casta”. È un giornalismo di verità, che mette al centro la dedizione assoluta alla storia, nell’ambito della quale il giornalista non è semplicemente un osservatore del fenomeno, il ricettore di una testimonianza, ma è parte integrante delle dinamiche che egli stesso mette in moto attraverso un’immersione completa nella materia oggetto d’inchiesta. È, in un certo qual modo, l’abolizione della “giusta distanza”.
Il lavoro di Gabriela Wiener, giornalista peruviana classe ’75, ora di base a Madrid, una delle voci di riferimento del periodismo latinoamericano, s’inserisce a pieno titolo in questa pratica di giornalismo di verità. In quella scuola del fare inchiesta che prende il nome appunto di “periodismo gonzo”, un giornalismo narrativo, basato su metodologie d’inchiesta a lungo-termine, frutto di approfondite indagini empiriche, agli antipodi dall’esasperazione da ultima notizia di certo fare giornalistico nostrano. Nel suo libro Corpo a corpo, (pubblicato in Italia da La Nuova Frontiera, traduzione di Francesca Bianchi), la reporter indaga le pratiche sessuali della società. Perché forse il modo migliore per conoscere una cultura è indagarne appunto le sue abitudini più segrete, conoscerne il “corpo”.
È un percorso a tratti sconvolgente quello raccontato da Gabriela Wiener nelle sue tredici crónicas che compongono il libro, dalle carceri sudamericane agli ambulatori dove, per poche centinaia di euro, giovani donne immigrate vendono i loro ovociti. La Wiener entra poi nelle dark room in cui si consumano incontri occasionali di scambi di coppia, frequenta l’oscurità delle notti del Bois de Boulogne dove giovani prostitute e transessuali sudamericani “lavorano” per qualche decina di euro a notte, fa visita a una giovane mistress celebre nell’ambiente Bdsm e a un simil-guru del sesso che vive con sei mogli poco fuori Lima….
Gabriela Wiener racconta tutto questo in prima persona. Fisicamente è con le persone di cui racconta, è essa stessa le persone di cui scrive. La sua è una parola carica di tensione che corre sui crinali più oscuri del nostro tempo. Ogni crónica è viaggio iniziatico ed esplorazione mai definitiva, sperimentazione stilistica e attraversamento, per avvicinamenti ogni volta più “incauti”, alla materia cangiante e ripida del contemporaneo.
“In questo esatto momento, nel ventre di una sconosciuta, sta crescendo un figlio mio. Devo chiamarlo in un altro modo. Tecnicamente non è mio figlio, anche se ha tutta la mia informazione genetica. Durante tutto il periodo della donazione i dottori lo chiamavano Ovocito, fino a quando non me lo hanno estratto”, scrive.
L’abbiamo incontrata a Roma, in occasione della presentazione di Corpo a corpo, al Salone dell’Editoria sociale.
 Come è iniziata la tua collaborazione con Etiqueta Negra? Come ti sei rapportata, all’inizio, con la pratica del “periodismo gonzo”?
Come è iniziata la tua collaborazione con Etiqueta Negra? Come ti sei rapportata, all’inizio, con la pratica del “periodismo gonzo”?
“Per me Etiqueta Negra è stata una scuola, il “luogo” in cui ho imparato a fare un tipo di giornalismo molto diverso da quello che si fa nelle redazioni dei grandi giornali tradizionali, per i quali già lavoravo e nei quali mi sentivo “ingabbiata”. Prima di iniziare a collaborare con Etiqueta Negra mi occupavo di cultura e di società, intervistavo registi, attori, artisti, scrivevo sempre del lavoro di altre persone. Non c’era la possibilità di fare ciò che a me interessava davvero, che è un giornalismo più personale. In quelle realtà mancava questo tipo di approccio, anche se avevo comunque la possibilità di scrivere. Articoli medio-lunghi, soprattutto, intorno ai 5000 caratteri. Quando Julio Villanueva Chang, che in quel periodo stava iniziando a costruire il suo gruppo di giornalisti per il primo numero di Etiqueta Negra, decise di chiamarmi conosceva il mio lavoro e il mio stile perché aveva letto quegli articoli e pensava fossi in grado di confrontarmi con il tipo di giornalismo che aveva in mente. Se da un lato, nei quotidiani per i quali lavoravo, venivo premiata e si complimentavano con me perché riuscivo a parlare di temi di cui nessuno voleva occuparsi e riuscivo a trovare storie inconsuete; dall’altro in realtà – professionalmente – venivo degradata da contratti fasulli, non ero pagata in maniera equa, avevo molto meno spazio di quello di cui avrei avuto bisogno per trattare in profondità una storia. Ed è stata proprio questa situazione di limbo, paradossalmente, che mi ha permesso di potere collaborare al 100 per cento con Etiqueta Negra. Altri miei colleghi, quelli che avevano contratti migliori con le testate nazionali e scrivevano in esclusiva per loro, erano blindati dalle redazioni. Io avevo, come ho detto, contratti precari e questo mi ha permesso di avere da subito la libertà di dedicarmi al nuovo progetto senza costrizioni.
La cosa più interessante per me all’epoca è stato confrontarmi con la nuova impostazione che Julio Villanueva Chang dava ai suoi giornalisti. Ci lasciava moltissimo tempo per documentarci sui casi che dovevamo trattare, dovevamo leggere molto, ci dava la possibilità di raccogliere materiale, di indagare la storia in profondità. Con Etiqueta Negra ho imparato davvero che cos’è il giornalismo sul campo, la totale immersione nella storia che si sta trattando. Ho imparato con loro a fare giornalismo d’inchiesta, di indagine, a lavorare e a scrivere sul lungo-periodo. Ci veniva data la possibilità di metterci in prima persona nella storia, di raccontarla dal nostro personale punto visto. Il punto di vista, lo stile. Questa per me era, ed è ancora oggi, la cosa più importante”.
Quali sono state le prime storie di cui ti sei dovuta occupare? In che modo hai organizzato il lavoro?
“La prima storia che ho scritto per Julio è stata la crònica dell’ayahuasca, la pianta allucinogena che gli indigeni dell’Amazzonia considerano sacra. Inizialmente doveva essere un articolo un po’ diverso da quello che poi ha preso forma, e che si può leggere anche, in Corpo a corpo. Io e un altro giornalista eravamo stati incaricati di scrivere una sorta di reportage epistolare, una lunga cronica della nostra esperienza con l’ayahuasca nella giungla peruviana in forma di lettere, sulla traccia di Lettere dello Yagé, il bellissimo libro in cui è raccolto il carteggio tra William Burroughs e Allen Ginsberg. Per preparare l’articolo abbiamo fatto un lunghissimo lavoro preparatorio studiando tutto ciò che potevano sui principi di questa pianta. Le caratteristiche scientifiche, le proprietà botaniche, il potere allucinatorio, la simbologia spirituale e la mistica legata al suo utilizzo nei rituali indios. Poi abbiamo avuto la possibilità di passare del tempo nella foresta amazzonica per sperimentare in prima persona gli effetti della pianta e per incontrare gli sciamani che praticano ancora oggi questi riti. Ci è stata data la possibilità di confrontarci davvero, in prima persona, con il tema di cui dovevamo scrivere e soprattutto in un modo molto approfondito. Un altro degli incarichi che ho ricevuto da Etiqueta Negra è stato quello di occuparmi della storia di Badani, il guru poligamo del sesso. Un personaggio conosciutissimo a Lima e in tutto il Perù, un uomo controverso, molto criticato dall’opinione pubblica. Quello che interessava il direttore di Etiqueta Negra, che interessava me in quanto reporter, era riuscire a conoscere e a capire dall’interno il punto di vista delle sue sei mogli. Perché queste donne stavano con lui? Come potevano accettare di vivere in quel modo? Volevamo riuscire a entrare nella loro quotidianità, nella loro casa per conoscere e raccontare la loro storia. Volevamo capire come fosse possibile che queste donne accettassero una condizione che, fino a quel momento dall’opinione pubblica, era sempre stata descritta come una moderna forma di schiavitù. Quello che si diceva di lui a Lima, il ritratto che ne restituivano i media, era quello di uno schiavista che costringeva le sue compagne a vivere in una condizione di coabitazione coatta, forzata. Noi volevamo sapere, volevamo andare a vedere cosa succedeva in quella casa.
Un punto fondamentale, che è una caratteristica del metodo di lavoro di Etiqueta Negra e ha rappresentato forse il massimo punto di rottura e d’innovazione rispetto a un certo tipo di fare giornalismo tradizionale, è il rapporto molto stretto, simbiotico direi, tra l’editore e i suoi giornalisti. Un editore che non commissiona semplicemente gli articoli, ma che accompagna i suoi reporter in tutte le fasi del lavoro, li indirizza e li sostiene. Dalla fase preparatoria, la ricerca delle fonti e della documentazione bibliografica, fino all’ultima stesura del pezzo”.
L “io” narrativo, che è la cifra di questa idea di scrittura giornalistica, è anche una “prima persona” politica? Se sì, in che modo esattamente?
“La scelta della prima persona narrativa non è casuale. Quello che io leggevo prima di fare la giornalista ha influito moltissimo sul mio modo di scrivere e nella concezione profonda che ho della letteratura e del mio mestiere. Prima di dedicarmi completamente al giornalismo mi occupavo di poesia. Ho sempre indagato un certo tipo di lavoro sulle parole, e sul corpo dello scrittore, del poeta. Leggevo, e leggo tutt’ora, moltissima produzione poetica, soprattutto quella delle poetesse americane degli anni’50, molte delle quali morte suicide. L’opera di Silvia Plath, quella di Anne Sexton ma anche i testi di Alejandra Pizarnik. È questo che mi interessava e che scrivevo quando ho iniziato a lavorare per i giornali. Questo tipo di tradizione stilistica. Una scuola di poesia intima e molto attenta anche alla corporeità della parola. La dimensione fisica, corporea, dell’atto di scrivere. Penso che la crónica, per il mio modo di rapportarmi allo scrivere, sia un lavoro molto fisico, un’attitudine corporea alla realtà che ci si trova a indagare. Investe tutti i sensi. Tutto confluisce nella scrittura. Quello che vedo, quello che ascolto, gli odori che sento, le percezioni fisiche e sensoriali, l’intimità che si crea con l’ambiente che mi circonda e con la storia che devo scrivere”.
Quale credi sia l’impatto sulla società di questo modo di fare indagine?
“In realtà credo che scrivere non serva a nulla. Credo, a dire il vero, che nessun tipo di arte o di letteratura, perché è di questo finalmente che stiamo parlando, serva davvero, o possa in qualche modo, cambiare il mondo. Quello che penso però è che ogni volta che si riesce a suscitare anche solo un piccolissimo cambiamento nel punto di vista o nella percezione di chi legge, si sia raggiunto un grande risultato. Che tutto ciò avvenga è già un atto politico. Probabilmente Rodolfo Walsh si sentiva più rivoluzionario che scrittore. I giornalisti della mia generazione invece, noi che cerchiamo oggi di fare un certo tipo di ricerca stilistica in America Latina, ci sentiamo forse più scrittori che rivoluzionari ma non penso sia questa la cosa più importante. Quello che credo sia davvero fondamentale comprendere è che anche solo il fatto di indagare la realtà, di scavarla, di andarci a fondo, è un atto politico. Già il semplice fatto di farlo è rivoluzionario. Quello che mi piace molto in questo momento, per esempio, è indagare la scrittura e le modalità in cui anche le persone comuni, chi non scrive per mestiere, usano la rete per parlare delle loro esperienza, del loro vissuto quotidiano; per creare un’opinione e discutere di ciò che vivono e vedono. Mi interessa come parlano di società, di politica, di sesso. Ritrovo spesso in questa vitalità, in questa volontà di metterci la faccia, di esporsi in prima persona, una forma di attivismo narrativo, che in fondo non è molto lontano da quello che faccio io quando scrivo.
Vorrei parlare però anche del giornalismo d’inchiesta, che ha un’altra impostazione rispetto a quella che adotto quando scrivo. Quei giornalisti sono persone che davvero possiamo chiamare eroi. Rischiano seriamente la vita ogni giorno per quello che fanno e si occupano di temi molto più politici perché vanno direttamente a indagare i meccanismi del potere, la corruzione di stato, i crinali più bui dei governi. Ho molti amici che fanno questo tipo di giornalismo, che rischiano la pelle ogni giorno, che perdono la vita. Come continua a succedere in Messico, sempre di più. Loro sì che si giocano tutto. Io ci metto la pelle, certo, il mio corpo, ma lo faccio in modo diverso. Credo fortemente però che queste due realtà, queste due impostazioni, possano convivere e che in fondo non siano così lontane”.
Corpo a corpo – di Gabriela Wiener.
ed. La Nuova frontiera. (traduzione di Francesca Bianchi).