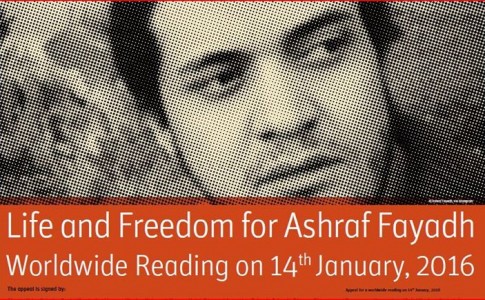“Non è che immaginassi questo alla mia età, anzi, avevo voglia di tutt’altro. Ma quando ti trovi sotto casa dei ragazzini, perché per me sono ragazzini, che hanno freddo e fame, che fai? Non li prendi in casa?”. Seduta al tavolo della cucina, Catherine parla senza quasi alzare lo sguardo dai porri e dalle carote che sta affettando. Fuori, il sole invernale del primo pomeriggio scava le montagne della Val Roja, lì dove le rocce si trasformano in gole scavate dal fiume. Nella stanza accanto quattro ragazzi eritrei stanno finendo di mangiare gli spaghetti; quando ci vedono arrivare la loro espressione perplessa si allarga in un sorriso timido. “Sanno appena qualche parola di inglese, comunicare non è facile”, scuote la testa Catherine. I ragazzi sono a casa sua da due settimane, non escono mai per paura di essere intercettati dalla polizia e rimandati in Italia. Non si affacciano nemmeno alla finestra, per paura che qualcuno li veda.
“Sono costretta a fare la spesa in un altro paese: ti immagini se qui mi vedono comprare due chili di banane quando tutti sanno che vivo da sola? Ma tanto lo sanno lo stesso. Capirai, un comune di tremila abitanti che d’inverno ne vede sì e no trecento. Ci prendono per dei gauchistes che aiutano i terroristi”.
Non è espressamente vietato ospitare qualcuno, ma ciò non toglie che si tratta di stranieri senza permesso di soggiorno. “Maggiorenni, per di più – sottolinea Catherine – il che significa che non possono nemmeno fare domanda di asilo come minori non accompagnati, anche se hanno soltanto vent’anni e sono reduci da un viaggio terribile, in cui hanno visto e subìto ogni genere di violenza”. È una nonna senza nipoti. Ci ha accolti con una reticenza che potrebbe sembrare rude se non mascherasse il pudore di chi non ama esporsi. Ha fatto la farmacista e ora, in pensione, avrebbe ben diritto a sedersi al sole, nel silenzio di questo paese verticale che si estende in altezza e fa pensare a una delle Città invisibili di Calvino: rocce sotto, pietre che lo acciottolano e sassi all’orizzonte. Paese resistente, che non si concede facilmente, come chi lo abita.
Catherine è recidiva, sono mesi che accoglie ragazzi e ragazze sperduti nella valle, arrivati da Ventimiglia in questi borghi quasi disabitati seguendo le rotaie del treno. Lo sa che aiutarli è rischioso, altri come lei sono già stati sottoposti a fermo obbligatorio in caserma, alcuni sono sotto processo – anche se in teoria non sarebbero perseguibili, almeno secondo la modifica del 2012 alla legge francese sul cosiddetto “reato di solidarietà”, che consente il soccorso a persone in difficoltà anche quando non hanno i documenti in regola. “Però se ti trovano con uno straniero in auto ti arrestano, perché nella legge non è contemplata la possibilità di dare un passaggio”, dice. Un insegnante è stato fermato al casello di Mentone con quattro migranti e si è preso una denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “È stato assolto ma adesso passare dall’autostrada è decisamente complicato», spiega Catherine. Il sottinteso è che, per l’ingenuità di uno solo, ora tutti devono trovare strade alternative e più complicate per passare il confine. Scuote piano la testa mentre taglia le cipolle a listelle sottili. Sono equilibri delicati, il clamore degli arresti e della stampa fa drizzare le antenne alle forze dell’ordine. In casa sua non sono mai entrati ma Catherine ricorda bene quello che è successo poco tempo fa a Cédric Herrou, il contadino di Breil-sur-Roya che ne ha aiutati centinaia: minacce di morte, denunce per aver aiutato degli irregolari, agenti antisommossa che fanno irruzione fra oche e galline della sua fattoria; infine una sentenza del tribunale di Nizza che non lo condanna al carcere ma si limita a una multa di tremila euro. Per ora.
“Mio padre ha 84 anni e vive a Clermont-Ferrand, non volevo che si preoccupasse ma a un certo punto ho dovuto dirglielo; non mi hanno mai fermata, ma se succede? Io sono sola, non volevo che telefonasse e non trovasse nessuno. Ora scherziamo, quando chiama mi chiede se mi hanno già messa dentro”. Sorride, ma si intuisce la nota di sconcerto per un destino bizzarro che l’ha portata a stare in pena per qualcuno che non conosce e sul cui destino non può influire.
“Come comincia? Prima è una colletta per i migranti, poi una minestra per gli accampati alla frontiera e alla fine qualcuno ti avvicina e dice ‘abbiamo trovato dei ragazzi per strada, ne puoi tenere due questa notte’?, e tu li prendi. I primi erano dei siriani, degli enfants gâtés, viziati e maleducati, se ne fregavano di quel che dicevo, fumavano in casa. La sera che sono andati via mi sono detta: mai più. Poi mentre rincasavo me ne sono trovata proprio qua sotto altri due: non mangiavano da due giorni. Li ho fatti entrare”.
Alla porta compaiono i ragazzi con i piatti sporchi, Catherine fa segno di lasciarli nel lavandino. “Alcuni di noi sono stati accusati di sfruttamento solo perché facevano lavare i piatti ai rifugiati che accolgono. Visto che la legge dice che se trai profitto dall’accoglienza sei perseguibile, la polizia si attacca a qualsiasi cosa”.
Prosegue: “Va così. Non vuoi e lo fai, perché l’alternativa è lasciarli soli. Ma non è facile, perché non parlano, non fanno niente, stanno tutto il giorno al cellulare o al computer nel tentativo di non spezzare l’unico filo che li lega alla famiglia, agli amici lontani. Qualche mese fa ospitavo delle ragazze e a un tratto sento un urlo terribile: una di loro era appena venuta a sapere della morte del fratello. Gridava, picchiava la testa sul muro – e ti assicuro che non è un modo di dire. Non riuscivo a parlarle perché non sapeva nemmeno una parola d’inglese. Voleva partire subito, senza conoscere le strade. Stavo per darle un calmante, ma se poi è allergica? La verità è che sei solo davanti a situazioni drammatiche, a vite di cui non sai nulla. Non hai strumenti”.
Mentre parla guarda il cellulare, racconta che le è appena arrivato un messaggio da un ragazzo che ha avuto in casa qualche mese fa. Cercava di passare il confine a Calais e l’hanno preso, ora è uno dei tanti dublinés. “Era disperato. È partito dal suo Paese minorenne, ha subìto di tutto: prigione, torture, fame; adesso era in Francia e si sentiva al sicuro. E invece è stato espulso e deve ricominciare da capo”. Scuote la testa, Catherine: “Dopo tutto quello che ha sofferto. Non capisco, io davvero non capisco”.
Ha trascorso tutta la sua vita adulta in Val Roja, in questa terra di nessuno, che non è più Italia e non è ancora Francia, paesi arroccati sui monti ma già levigati dall’aria del mare, prati impervi e sentieri di contrabbandieri di sale, diventati piste per passeurs. Oggi i valichi sono presidiati dalla polizia e dicono che ci sono anche i corpi speciali. “Perché li lasciano arrivare fin qui se poi li vogliono bloccare quando cercano di scendere verso Nizza? Per fare scena e dire che sono bravi, loro, ad arrestare clandestini, che tutto è sotto controllo e l’Etat d’urgence funziona a meraviglia”.
È stanca, Catherine. “Uno pensa alla pensione come al momento in cui potrà riposarsi e invece io lavoro più di prima”, sospira. Ci sono le riunioni dell’associazione per coordinare le azioni di solidarietà e sostenere i compagni che devono subire i processi, poi bisogna raccogliere fondi, portare pasti a chi si accampa a Ventimiglia – “che tra l’altro è vietato da un’ordinanza del Comune” – e, ovviamente, provvedere ai ragazzi. “Ora devo andare a trovare mio padre e sai cosa? Aspetto quel momento come una vacanza”, dice. Si muove lenta nella cucina che sembra cucita addosso a lei – se vuoi una sedia in più devi prenderla dal piano di sopra – e ora quella piccola casa si trova a dividerla con quattro uomini. “Non vedo l’ora di tornare da sola”, confida con un mezzo sorriso. Ma forse non ci crede neanche lei.